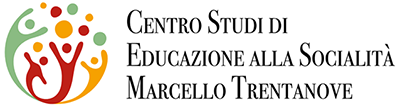– di Beniamino Deidda –

Da molti mesi ormai si discute degli effetti del covid-19 sulle scuole e sull’attività scolastica.
Nel momento in cui scriviamo la confusione è altissima: in tutte le scuole superiori è vietata l’attività scolastica in presenza degli alunni, tutti costretti a seguire le lezioni da casa o comunque da remoto. La stessa disposizione vale per gli alunni della terza media. Solo le classi prime e seconde medie sono a scuola per seguire le lezioni in presenza. Lo stesso avviene per la scuola elementare. Ma non per tutti valgono le stesse regole. Per effetto dell’autonomia delle regioni in materia di salute pubblica, alcuni governatori regionali hanno preso l’iniziatica di vietare la presenza a scuola indistintamente per tutte le classi. Ne sono seguiti ricorsi al TAR, con le inevitabili pronunzie contrastanti da parte di TAR diversi. Massima è dunque la confusione ed inevitabile lo stato di incertezza dei cittadini.
Si aggiunga che fino dal marzo scorso proprio sulla scuola si è combattuta una aspra contesa politica. Da una parte i critici della politica governativa, accusata di non sapere garantire a bambini e ragazzi un diritto essenziale; dall’altra i difensori delle scelte assunte dal governo e coloro che pensavano che il diritto alla salute e la difesa della medesima dovessero prevalere su ogni altro diritto o considerazione.
Per parte nostra vorremmo tentare di richiamare l’attenzione del lettore sulla reale posta in gioco che si nasconde dietro la scelta: scuola sì o scuola no; didattica in presenza o didattica a distanza. Si tratta di una questione che non si atteggia diversamente a seconda dell’andamento della curva dei contagi o delle presenze nei posti di terapia intensiva negli ospedali, come qualche volta si ritiene. Tutto si riduce a cogliere la funzione della scuola durante l’emergenza creata dalla pandemia in corso. Tra i tanti che scrivono e riflettono sugli effetti della pandemia, un buon numero esprime la convinzione che in tempi eccezionali sia del tutto ragionevole far saltare le priorità e i ritmi della nostra vita sociale e che i principi che regolano i rapporti tra cittadini e istituzioni possano essere stravolti. Ma il nostro sistema di diritti e doveri, disegnato dalla Costituzione è regolato diversamente. La Costituzione prevede al suo interno anche le eccezioni dovute all’emergenza e le regola stabilendo priorità e limitazioni. Non bisogna confondere lo stato di emergenza con lo stato di eccezione. Lo stato di emergenza nell’età del costituzionalismo democratico non deve mai mettere da parte gli istituti di garanzia costituzionale e il principio di proporzionalità quale metodologia di coordinamento dei principi nel moderno pluralismo costituzionale. Perciò, quando si tratta di stabilire quali valori prevalgano e quali siano invece i diritti che eccezionalmente possono essere sacrificati, occorre interpretare correttamente il disegno che la Costituzione ha posto per regolare la nostra convivenza.
Abbiamo sentito dire in questi mesi passati, in un dibattito talora sconclusionato, che il diritto alla salute prevale su ogni altro diritto e che dunque per preservare la salute collettiva si possono sacrificare anche i diritti di rango elevato. C’è un nucleo di verità in questa affermazione, se non altro perché senza la garanzia della salute e della vita è difficile godere di altri diritti. Tuttavia, quando si devono trovare le soluzioni e i modi per individuare il punto di equilibrio tra la necessaria conservazione del bene salute e lo svolgimento di altre attività che realizzano diritti altrettanto importanti, occorre trovare le misure giuste e individuare correttamente quali siano le priorità nella vita civile e sociale del paese.
In realtà durante l’anno scolastico 2019-20 abbiamo visto il governo chiudere tutte le scuole per evitare la diffusione del contagio e favorire modalità didattiche a distanza in tutti gli istituti scolastici.
Nello stesso periodo le scuole di quasi tutti i paesi europei sono rimaste aperte con opportune misure di protezione e idonei aggiustamenti.
Il lungo periodo di didattica a distanza, che è durato fino alla conclusione dell’anno scolastico, ha mostrato subito i suoi limiti. Le risorse messe in campo dalle scuole e dalle famiglie, diverse per capacità e organizzazione, ci hanno mostrato un quadro preoccupante in relazione al rispetto di fondamentali principii costituzionali, quali il diritto inviolabile allo sviluppo della personalità di tutti i ragazzi (art. 2 C.) e il principio di eguaglianza di tutti i cittadini, “senza distinzione di condizioni personali e sociali” (art. 3 C.).
Si è detto da molti che proprio la salvaguardia della salute dei bambini, dei ragazzi e dei docenti e del personale amministrativo richiedeva la chiusura delle scuole e sconsigliava le lezioni in presenza. Ma l’esempio contrario di altri paesi europei di sperimentata democrazia ha mostrato la possibilità di contemperare diversamente l’esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti.
Del resto, non sono mancati esempi di un diverso contemperamento delle varie esigenze. Le fabbriche e i luoghi di produzione di beni e di lavoro, soprattutto, sono rimasti aperti, favorendo il lavoro a distanza, quando possibile, ma provocando di fatto la presenza nei luoghi di lavoro di milioni di persone. Con inevitabili affollamenti sui treni, sugli autobus, nelle metropolitane e negli stessi stabilimenti di lavoro. Si è trattato di una scelta, certo meditata, che però in certe ragioni del nostro paese ha avuto tragiche conseguenze sul piano della salute.
La verità è che in casi come quello che attraversiamo, i governanti sono chiamati a stabilire ciò che nel nostro patto sociale fondamentale può essere sacrificato e quali principi invece devono essere osservati fino in fondo, se non si vuole stravolgere la fisionomia dello stato di diritto e della nostra democrazia.
Ebbene la scuola è uno di quei diritti che non possono essere sacrificati durante l’emergenza determinata da una epidemia. I nostri governanti, e in generale la nostra classe politica, sono capaci di vedere chiaramente che, per salvaguardare la salute, non si può rinunciare a produrre beni e servizi che garantiscano la nostra nutrizione. Ma sono del tutto incapaci di comprendere l’impossibilità di rinunziare alla scuola in presenza. Questo si spiega in parte con la storia del nostro paese e con la storia relativamente recente della nostra democrazia .
Ma se si pone attenzione ai principi della nostra C, si capisce che la scuola non può essere sospesa. La scuola non garantisce solo l’istruzione dei fanciulli e dei ragazzi; è anche un potente fattore di eguaglianza tra cittadini che si trovano in condizioni molto diverse sul piano personale e sociale. Tutti sappiamo con certezza che alla fine di mesi, o di un’intero anno, di didattica a distanza si dovrà registrare fatalmente un aumento delle diseguaglianze: tra le famiglie più o meno provvedute sul piano culturale, tra i ragazzi che possedevano il computer e quelli che non lo possedevano; tra coloro che potevano fruire di un sostegno familiare e quelli che non ne avevano la possibilità.
E’ facile capire che un bambino di sei anni non può imparare a scrivere e a leggere davanti a un computer e senza la guida di un insegnante, come è facile capire che ragazzi di 13, 14 o 15 anni perderanno l’occasione unica di misurarsi e crescere con la frequentazione dei loro compagni a scuola. Non sono occasioni che possano essere recuperate: essi non avranno più 13,14 o 15 anni, ci sarà per sempre un buco nella loro formazione.
Così accade che, in un colpo solo, la chiusura della scuola priva i ragazzi di un diritto che l’art 2 definisce ‘un diritto inviolabile dell’uomo’ e impedisce di ridurre le diseguaglianze tra i cittadini come impone l’art. 3 cpv. (“E’ compito della repubblica rimuovere gli ostacoli….”).
Ma neppure durante l’emergenza è consentito allo Stato di violare il principio di eguaglianza, né si possono violare i diritti che attengono alla dignità della persona.
Il Governo e la ministra Azzolina ritengono che il rimedio idoneo alla mancanza di scuola in presenza sia costituito dalla didattica a distanza. Anzi, qualche membro del governo si è lasciato scappare l’affermazione che questa, con i dovuti miglioramenti, sarà la scuola del futuro. E’un altro segno della scarsa considerazione in cui è tenuta la presenza in classe degli alunni. Eppure anche qui la corretta interpretazione della Costituzione aiuta.
La lettura dell’articolo 34 C., è la vera e propria chiave del sistema costituzionale sulla scuola. L’articolo si apre con quel primo comma “la scuola è aperta a tutti”, che è il comma più breve di tutta la Costituzione, ma capace di esprimere una serie di concetti di grande importanza. Vorrei far notare la scelta delle parole fatta dai costituenti. L’articolo non significa solo quel che comunemente si ritiene, che cioè l’istruzione deve essere consentita a tutti. I costituenti sapevano misurare le parole. Non hanno scritto ‘l’istruzione è aperta a tutti’, ma ‘la scuola è aperta a tutti’. La scuola è ‘aperta a tutti’ significa molto di più: perchè garantisce a tutti di poter frequentare un’istituzione, cioè un luogo che è anche fisico, in cui ci si incontra per apprendere e nel quale si apprende davvero solo quando ci si incontra. La scuola cioè è il luogo della socialità, dove ci si misura, ci si confronta, si entra in relazione, in un intreccio essenziale per la formazione dell’uomo. L’apprendimento e l’educazione non possono essere solitari, hanno bisogno di un luogo in cui ci si incontra e ci si confronta per apprendere insieme. Per questo la C. ha utilizzato l’espressione la scuola è aperta a tutti. Che l’istruzione fosse diritto di ciascuno lo aveva già detto nell’art. 2, quando aveva garantito i diritti inviolabili dell’uomo, tra i quali l’educazione e lo sviluppo della personalità. E non c’era bisogno di ripeterlo nell’articolo 34. Il quale, invece, vuole garantire a ciascuno la frequenza fisica di una comunità nella quale ci si educa, quella in cui la vicinanza fisica e la comunicazione, anche non verbale, sono insostituibili. Questo non significa naturalmente che non possano essere usate le tecnologie o l’informatica come strumenti di apprendimento. Ma essi non potranno mai sostituire la scuola come luogo fisico, necessario allo sviluppo della personalità. Una scuola, con le aule, con la presenza dei ragazzi, dovrà essere sempre aperta per tutti, come vuole appunto la Costituzione.
Insomma il limite di fondo nell’esperienza della scuola italiana sta nel fatto che da molti decenni nessun governo ha capito che la questione della scuola era una grande questione nazionale. E’ mancata l’intuizione, che oggi percepiamo più chiaramente, che la crisi di fondo della società italiana imponeva di affrontare il tema della scuola come necessario rivolgimento nazionale. E’ la scuola la leva del possibile, e non più rinviabile, cambiamento. Una classe politica consapevole dell’importanza della scuola per il futuro della nazione non penserebbe mai di chiudere le scuole, esattamente come avviene negli altri paesi europei, certamente più lungimiranti del nostro. Tenerle aperte si può: basta attrezzare gli spazi, dimezzare il numero degli alunni per classe (come è avvenuto in Francia), aumentare il numero degli insegnanti, ricorrere ai doppi turni. E poi: organizzarsi all’esterno delle scuole per rendere possibile la loro frequentazione: potenziare i trasporti, moltiplicare treni e autobus, diversificare gli orari di ingresso a scuola, evitare gli affollamenti sui bus, garantire le distanze tra gli utenti.
Si dirà che tutto questo avrebbe richiesto uno sforzo enorme per l’intero paese. Ed è vero: per troppi anni si è cercato di sistemare i conti tagliando le risorse alla scuola (e alla sanità). Ricordiamo tutti gli anni dei tagli cervellotici della Gelmini o la “buona scuola” del governo Renzi. Erano appunto anni nei quali la scuola non aveva nessuna centralità. Oggi raccogliamo i frutti di quella politica insensata. Una politica che nascondeva la sua miseria dietro il paravento della retorica: “la scuola è il futuro del nostro paese”, “i ragazzi sono la risorsa più preziosa che abbiamo” e via con le dichiarazioni fumose.
Oggi vediamo il disastro, inevitabile epilogo di quella miopia: scuole fatiscenti, classi pollaio, un sistema di reclutamento degli insegnanti inadeguato da decenni, docenti trattati economicamente come impiegati di quarto livello. L’epidemia in corso ha avuto l’effetto di rendere chiaro il disastro e come sia difficile porvi rimedio. Ma oggi siamo al bivio: già mancano i medici, i ricercatori, gli informatici ecc. Se ora chiudiamo le scuole, come si formeranno? La soluzione appare chiara a tutte le persone di buon senso: il maggiore sforzo economico deve essere indirizzato a salvare la scuola per tutti: un numero decente di alunni per classe, edilizia scolastica rinnovata e funzionale, reclutamento e numero di insegnanti per scuola finalmente all’altezza di un paese civile, adeguato numero di insegnanti specializzati per il sostegno, stipendi decorosi per i docenti. La scuola oggi deve poter godere di risorse maggiori di tutti gli altri comparti. Una democrazia sana può forse mangiare di meno (serve contro l’obesità), ma non può avere meno scuola in presenza per tutti.
Non sono le ricette che mancano. Manca solo la convinzione che far funzionare finalmente la scuola secondo i principii voluti dalla Costituzione è l’unico rimedio che può salvare questo sfortunato paese.