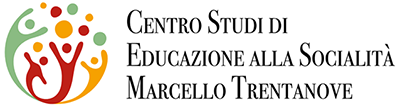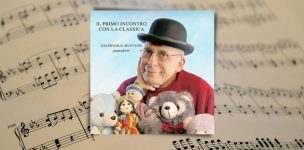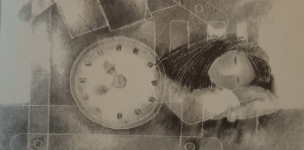Franca Alacevich

I centri sociali e i circoli ricreativi e culturali, e ogni altro luogo di aggregazione comunitaria, hanno subìto da tempo un processo di cambiamento che ne ha ridotto le potenzialità di integrazione sociale, di relazioni intergenerazionali, e persino di formazione politica e sociale in senso lato. Da tempo, infatti, e ben prima della pandemia hanno visto diminuire la frequentazione dei giovani, se non per iniziative di formazione specifica, come le scuole di danza o i corsi di lingua straniera, per esempio. Da tempo sono divenuti momenti ricreativi quasi esclusivamente per anziani, e quasi esclusivamente per attività di relazione e di gioco, dal gioco a carte alla tombola alle bocce. Da tempo, e anche in collegamento con l’erodersi dell’attrazione verso la vita politica e i partiti, hanno ridotto le attività di confronto e formazione, di sensibilizzazione e di attivazione, a livello locale, della popolazione.
Questo quadro a tinte fosche non riguarda tutti i centri e tutti i circoli, ovviamente, così come non riguarda tutti i territori del nostro paese, e certamente la Toscana e l’area metropolitana fiorentina in particolare hanno vissuto questo processo con minore intensità. Alcuni hanno mantenuto un livello di attività più nutrito e più variegato. Ma la sensazione diffusa è che la maggioranza di essi abbia visto un impoverimento complessivo della loro attività e una disaffezione crescente soprattutto dei giovani e dei giovani adulti, già prima della pandemia che ha colpito gravemente la società nell’ultimo anno e mezzo. Si tratta di una tendenza di lungo periodo, dunque, che ha avuto una forte accelerazione in conseguenza del primo lock down, da marzo 2020, e delle doverosamente rigide regole che successivamente, e sino ad oggi, sono state adottate. Solo ora, a fine maggio 2021 si inizia a vedere la possibilità di riaprirli.
Questa tendenza di lungo periodo, aggravata dalla pandemia, non è un problema soltanto per i centri sociali e i circoli ricreativi e culturali. Certo, essi hanno oggi problemi di sostenibilità economica, e di rapporti di lavoro con i, pochi, dipendenti che ne assicuravano l’apertura. Ma l’erodersi del loro ruolo di aggregazione sociale rappresenta un problema anche per la società nel suo complesso, a partire dalla società locale e ad arrivare fino alla realtà regionale e nazionale. Vediamo perché.
Possiamo utilizzare una metafora per descrivere la società che è molto presente sia negli studi delle scienze sociali che nel dibattito comune: la metafora della società come “tessuto”, e si usa dire appunto che la società è un tessuto sociale. Un tessuto è composto da un ordito e da almeno una trama che unisce i fili dell’ordito, creando così un insieme che tiene, che regge, e che tuttavia con l’usura e con il tempo può ridursi in brandelli se non viene accuratamente manutenuto. Alla stessa stregua, possiamo considerare gli individui e i gruppi sociali come l’ordito della società, e ciò che li tiene insieme, come una trama, sono i legami sociali tra di essi.
Una società coesa e solidale, ben integrata, può essere rappresentata come un buon tessuto, solido, resistente alle sfide sempre presenti nelle mutevoli condizioni cui è sottoposta, dai cambiamenti tecnologici allo sviluppo di relazioni sempre più impersonali, dalla globalizzazione alla crescente polarizzazione sociale che vede crescere le diseguaglianze. Tuttavia, anche il tessuto sociale, come il tessuto in senso proprio, richiede cura e manutenzione. Se i legami sociali si erodono, e non sono in grado di generare coesione tra individui e gruppi sociali, la società entra in una fase di disgregazione, dagli effetti non sempre prevedibili, e comunque forieri di tensioni. Una società attraversata da conflitti, popolata da soggetti individuali poco integrati tra di loro, e tesi a realizzare interessi particolaristici, assume al contrario le sembianze di un tessuto eroso, sfilacciato, che rischia di ridursi in brandelli.
Sin dagli anni Ottanta del secolo scorso abbiamo assistito ad un processo di crescente individualizzazione, ed è proprio a partire da questi anni che i centri sociali e i circoli ricreativi e culturali hanno subì il processo cui si faceva prima riferimento. Più recentemente, la grave crisi finanziaria iniziata nel 2008 – e non ancora superata all’arrivo della pandemia – ha provocato ulteriori problemi, aggravando le disuguaglianze e la polarizzazione sociale. E poi è arrivata la pandemia, con i suoi effetti gravissimi: da un lato, ha rafforzato ancora di più le disuguaglianze; dall’altro lato, ha isolato le persone e reso molto difficile la vita dei gruppi sociali. L’aggregazione è divenuta non soltanto più difficile – come prima – ma addirittura impossibile per un lungo periodo, o possibile solo nella forma “da remoto” che rende molto più difficili e comunque più impersonali le relazioni. Tutti i luoghi di aggregazione sono stati chiusi e poi se ne è ridotta l’agibilità: dalle scuole alle chiese, dai luoghi dello sport a quelli sociali, ricreativi e culturali. E i centri e i circoli locali hanno sperimentato quanto e più di altri luoghi di aggregazione questa erosione della loro possibilità di essere spazi di aggregazione sociale, di incontro tra generazioni, di espressione per le persone che li frequentano, di occasioni di svolgere attività e di confronto. Oggi sono, pertanto, a forte rischio, anche per i problemi economici che stanno affrontando. E proprio nelle ultime settimane alcuni articoli dei quotidiani lo hanno documentato.
Nel frattempo, stiamo vedendo gli effetti dell’isolamento sociale sulle persone. Molti anziani sono troppo soli e non poter frequentare i circoli li ha resi ancor più soli e abbandonati. Molti giovani, soprattutto gli adolescenti, stanno attraversando una fase importante della loro vita con grande difficoltà: sono cresciute le patologie alimentari, dall’anoressia alla bulimia; è aumentata la sindrome depressiva e ansiosa nei giovani e persino i tentati, e qualche volta ahinoi riusciti, tentativi di suicidio. Lo hanno documentato ricerche condotte in Cina (Xinyan Xie et al., 2020), egli Stati Uniti (Stephen W. Patrick et al. 2020), in Canada (Raising Canada 2020), in Scozia (Hodge, 2020), nel Regno Unito (Pierce et al. 2020; Loades et al. 2020). In Italia, il recente Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità sulla promozione della salute mentale infantile in tempo di covid-19 (ISS, 2020). A questi studi si aggiungono ricerche internazionali come quelle condotte dall’Università di Harvard (COVID-19 International Behavioral Science Working Group; così come i richiami delle organizzazioni internazionali: dal Comitato sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza presso le Nazioni Unite, al World Economic Forum.
Proprio il World Economic Forum (2020) ha indicato i modi per affrontare il problema: investire in programmi di prevenzione e cura della salute mentale e psico-sociale di bambini e adolescenti; e soprattutto attuare programmi e servizi community-based tarati sui loro bisogni e tener presente che nelle decisioni vanno coinvolti direttamente, secondo lo slogan “non per loro ma con loro”.
Si potrebbe partire proprio da questa indicazione per immaginare una pista di lavoro per i centri e i circoli in vista della loro prossima riapertura. Non conviene aspettare il momento della riapertura, e non si può pensare di ripartire come prima. Si potrebbe approfittare di questa lunga fase di chiusura per immaginare la ripartenza come una vera e propria “opportunità”, programmandola sin da subito, anche se dovesse tardare ancora – condividendo l’idea che intempestive riaperture possano generare più problemi di quanti ne risolvano.

Cogliere questa drammatica situazione come una vera e propria occasione ha almeno tre importanti significati. È un’occasione per ripensare gli spazi dei centri e dei circoli, anche tenendo conto che con la presenza del virus si dovrà convivere a lungo: si tratta di riorganizzarli in funzione della necessità del distanziamento fisico, della areazione, della riduzione dell’uso condiviso di oggetti e attrezzature. È un’occasione per ripensare le attività da fare in questi rinnovati spazi, che siano attività adeguate ai bisogni della popolazione locale di riferimento, dagli anziani ai bambini. È, infine, un’occasione per costruire modalità efficaci di sostenere l’integrazione tra le generazioni, vero strumento per la manutenzione di un tessuto sociale che sia coeso, che non perda la memoria, che sappia dare risposte ai nuovi bisogni, che sia attrattivo per anche per i più giovani.
Da un punto di vista metodologico, cogliere questa occasione impone di pensare di curare soprattutto tre aspetti e di programmare la ripresa ponendo attenzione ad essi, quali che siano le attività che ciascun centro e ciascun circolo deciderà di mettere in campo. Le attività sono, infatti necessariamente diverse dall’uno all’altro, perché dipendono da molti fattori, e soprattutto dagli interessi e dai bisogni della comunità locale di riferimento, dalle disponibilità e dalle aspettative dei soggetti che la popolano. Tuttavia, l metodologia di approccio alla programmazione può avere una impronta comune, nonostante le diversità.
Quali sono gli ingredienti di un progetto di successo? Quale metodo seguire nella riprogrammazione in vista dell’apertura? Gli ingredienti irrinunciabili sono almeno tre, altri potranno poi essere previsti caso per caso.
- Nel disegnare il futuro, nel progettare il ripensamento degli spazi e delle attività, è opportuno coinvolgere sin dal primo momento, sin dall’inizio della progettazione, i soggetti che ne sono e ne saranno destinatari – progettare, cioè, con loro, non per loro. In tutte le ricerche condotte sulle politiche di successo – che siano politiche pubbliche o private – un aspetto risalta nettamente: il loro disegno coinvolge sin dal primo momento i soggetti interessati dalla singola politica. Tutte le volte che non sono coinvolti, le politiche sono al meglio meno efficaci, al peggio un disegno che non raggiunge gli obiettivi prefissati.
- Nell’iniziare i lavori per attuare il programma di ripensamento degli spazi è molto efficace mettere all’opera insieme tutte le generazioni, tutti i soggetti, sfruttando le disponibilità di ciascuno, le loro diverse abilità e competenze. Fare le cose insieme è il modo migliore per creare legami tra soggetti di generazioni diverse, di diversa estrazione sociale, con diverse capacità e disponibilità. Ma lavorare insieme ha anche un altro effetto positivo, e rilevante per le attività future: fa sentire a tutti che quei luoghi in cui lavorano insieme, anche e spesso manualmente, sono i loro luoghi, se ne appropriano in qualche modo e un domani li vivranno non solo con maggiore attenzione alla loro manutenzione e alla loro vita ma anche con spirito creativo e innovativo e senso di appartenenza.
- Sia nella fase di disegno del futuro che, e soprattutto, nella fase di riavvio delle attività è opportuno immaginare e strutturare il futuro all’interno di una fitta rete territoriale di strutture, in un gioco di sinergia reciproca e di valorizzazione delle potenzialità e delle competenze specifiche di ciascun nodo della rete. Solo a mo’ di esempio, il rapporto con le scuole del territorio può valorizzare sia il ruolo delle scuole che quello dei centri e dei circoli, prevedendo attività che si realizzino insieme, che sfruttino tutte le risorse del territorio – così facendo si legano queste strutture tra di loro e si legano tra di loro le persone che le popolano. In passato, almeno in alcune zone, la separatezza è stata la cifra che ha guidato un po’ tutti, con qualche duplicazione di interventi – a discapito di ciascuno di essi – e con la difficoltà di realizzare alcune iniziative – per l’incapacità di utilizzare tutte le risorse disponibili sul territorio. Anche in questo si può ravvisare una buona occasione per il futuro di questa attuale drammatica situazione.
Certamente ogni centro e ogni circolo ha le sue caratteristiche, così come diversa è l’area in cui insiste, e dunque il contenuto specifico di ogni disegno per il futuro sarà diverso da centro a centro, da circolo a circolo. Tuttavia le tre direttrici sopra ricordate sono di carattere metodologico, e possono valere per tutti.
Per facilitare questo progetto, le strutture provinciali, regionali e nazionali che legano i centri e i circoli tra loro giocano un ruolo molto rilevante. Possono fornire uno stimolo per una progettazione delle riaperture che segua la strada indicata e sia più efficace. Possono dare visibilità ai progetti, alle loro modalità di realizzazione, ai risultati che stanno via via ottenendo, attraverso i loro siti web, iniziative pubbliche, persino gare a premi. Questa visibilità può, a sua volta, favorire l’emulazione, la diffusione di buone pratiche. Può anche, e non è affatto cosa secondaria, dare un riconoscimento pubblico a chi li sta realizzando. Il riconoscimento sociale è fonte di soddisfazione ma è anche una delle molle più efficaci per favorire e manutenere la motivazione a impegnarsi.
Riferimenti
COVID-19 International Behavioral Science Working Group (2020), Evaluating COVID-19 Public Health Messaging in Italy: Self-Reported Compliance and Growing Mental Health Concerns, https://gking.harvard.edu/files/gking/files/covid-italy.pdf
Hodge L. (2020), One in three children are suffering mental health issues due to the coronavirus, in Daily Record, https://www.dailyrecord.co.uk/lifestyle/family-kids/one-three-children-suffering-mental-22814057
ISS, Istituto Superiore di Sanità (2020), Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno della salute mentale nei minori di età durante la pandemia Covid-19, Gruppo di lavoro ISS Salute mentale ed emergenza COVID-19, Rapporto ISS COVID-19 n. 43/2020, https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+43_2020.pdf/32ba5573-8107-647c-3434-f307dd7dcaee?t=1591875745289
Loades M.E. et al. (2020), Rapid Systematic Review: The Impact of Social Isolation and Loneliness on the Mental Health of Children and Adolescents in the Context of Covid-19, in Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, n. 59, DOI https://doi.org/10.1016/j.jaac.2020.05.009
Patrick S.W., Henkhaus L.E., Zickafoose J.S. et al. (2020), Well-being of Parents and Children During the Covid-19 Pandemic: A National Survey, in Pediatrics, Official Journal of the American Academy of Pediatrics, DOI https://doi.org/10.1542/peds.2020-016824
Pierce M. et al. (2020), Mental health before and during the Covid-19 pandemic: a longitudinal probability sample survey of the UK population, in The Lancet Psychiatry, DOI https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30308-4
Raising Canada (2020), Threats to Childhood in Canada and the Impact of Covid-19, https://childrenfirstcanada.org/wp-content/uploads/2021/03/RaisingCanadaReport_Final_Sept.pdf
World Economic Forum (2020), A Globa Framework for Youth Mental Health, https://www.weforum.org/reports/a-global-framework-for-youth-mental-health-db3a7364df
Xinyan Xie B.A., Qi Xue M.P.H., Yu Zhou B.A. et al. (2020), Mental Health Status Among Children in Home Confinement During the Coronavirus Disease 2019. Outbreak in Hubei Province, China, in Jama Pediatrics, n. 174; DOI https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2020.1619